La conversazione qui pubblicata è estratta dal libro Una scelta per Milano. Scali Ferroviari e trasformazione della città (Quodlibet), a cura di Laura Montedoro: un corposo studio corale dedicato ai sette scali ferroviari milanesi dismessi che rappresentano un’occasione eccezionale e irripetibile di trasformazione urbana e di messa a punto di un’idea di città.
Il volume raccoglie pertanto numerosi contributi secondo uno schema tripartito: una prima parte contiene i saggi d’indirizzo volti a delineare strumenti e obiettivi del progetto urbano contemporaneo. La seconda parte presenta le esplorazioni progettuali per il riordino degli scali e una raccolta di casi studio. La terza, infine, propone una sorta di verifica a più voci delle ipotesi sviluppate nelle prime due, interrogando sia architetti e urbanisti, come Emilio Battisti, Pierluigi Nicolin e Luigi Mazza, sia personalità extradisciplinari di assoluto rilievo, come Ermanno Olmi, partendo dall’assunto che per capire una città sono necessari molti punti di vista, compreso quello del cinema, spesso trascurati dal mondo accademico ma forse gli unici in grado di restituire quel sentimento unico che Christopher Alexander chiama “the magic of the city”. Tre diverse forme di narrazione tenute insieme dal medesimo intento: offrire materiali di riflessone per promuovere un ampio e partecipato dibattito sul futuro di Milano.
Il cinema rivela il carattere di Milano? Quale identità della città ci restituisce?
Milano è la città della modernità in Italia. È la città in cui, già dall’Unità d’Italia in avanti, nasce l’industria, di lì nasce la società di massa e poi la civiltà dei consumi. Si potrebbe pensare che Milano è anche la città dove il cinema trova il suo habitat naturale, la sua culla. Così non è, perché sappiamo che il cinema nasce a Torino e poi si trasferisce a Roma negli anni trenta. C’è un libro di Mario Soldati, Le due città (1964), che racconta proprio il passaggio del cinema da Torino a Roma. Nel ’37 nasce nella capitale Cinecittà: da lì in poi Roma è la città dove si fa il cinema in Italia. È vero che Milano ha una serie di fotografi che poi diventano registi, come Luca Comerio, ma è vero anche che la prima immagine di Milano attraverso il cinema è di un film romano del 1932, Gli uomini che mascalzoni, di Mario Camerini, con un giovane Vittorio de Sica come protagonista, in cui è significativo che l’ambientazione sia la Fiera Campionaria, ovvero un luogo di sintesi della modernità. C’è una recensione di Filippo Sacchi, intellettuale antifascista, allora critico cinematografico del Corriere della Sera, che rileva come Milano fosse bella al cinema, come fosse fotogenica. Queste le premesse. Ciò detto, l’immagine di Milano - e più in generale delle nostre città - attraverso il cinema si può cogliere solo nel dopoguerra, perché il cinema italiano degli anni trenta è quello dei “telefoni bianchi”, un cinema soprattutto di interni. È a partire dal Neorealismo che il cinema comincia a esplorare le città e poi l’Italia intera. E questo ci riporta a Milano. Il grande film neorealista milanese è Miracolo a Milano (1951) di Vittorio De Sica, lo stesso De Sica che avevamo incontrato vent’anni prima come attore, qui è regista di un film scritto da Cesare Zavattini che aveva lasciato Milano per Roma dopo la seconda guerra mondiale. Ricordo che Cesare Pavese definì Vittorio De Sica il più grande narratore del dopoguerra. C’è la Milano delle periferie, del Martinitt e dell’Ortica; l’immagine che però si ricorda del film è piazza del Duomo, con le scope che volano verso il cielo.
Tra l’altro, se non ricordo male, gran parte del film è girato dall’alto, utilizzando precisamente la massicciata della ferrovia che porta alla stazione di Lambrate…ma torniamo all’immagine forte di cui dicevi.
Piazza del Duomo è il primo grande simbolo della città che il cinema riconosce. E qui c’è una considerazione più generale da fare: Alfred Hitchcock, nella conversazione con François Truffaut, afferma, se ricordo bene, che per l’Olanda il pubblico aspetta di vedere campi di papaveri e mulini a vento, nel senso che per ambientare un film si deve partire dai luoghi identitari forti, che non hanno bisogno di essere spiegati.
Il primo luogo di forte identità che il cinema racconta a Milano è il Duomo. Nel lavoro che ho fatto con Giovanni La Varra, Scene milanesi, un montaggio di scene cinematografiche organizzate per temi, uno dei capisaldi è il Duomo. L’altro che ricorre, ma ci torneremo dopo, è la Stazione Centrale. Nel bellissimo libro di Luca Doninelli, Il crollo delle aspettative (2005), emerge chiaramente che l’altro grande edificio simbolo della città è proprio la Stazione. Cosa sono queste due cattedrali, l’una antica e l’altra moderna? Sono dei luoghi che raccolgono; in cui arriva il pellegrino e capisce di essere arrivato al termine del suo viaggio.
Mi viene in mente Totò, Peppino e la malfemmina che mette in scena entrambe…
In effetti quello è un film importante. Intanto, per capirlo, occorre ricordare che è una pellicola del ‘56, un momento prima del boom economico, quando gli italiani finalmente si incontreranno e si mescoleranno tra loro. Qui ancora non si sono incontrati, pertanto Milano per un napoletano è un altrove. D’altra parte quelle scene ce le ricordiamo tutti: l’arrivo di Totò e Peppino vestiti come cosacchi, o la gag con il vigile in piazza del Duomo. È utile ricordare che i film comici di quegli anni, penso anche a Il vedovo (1959) di Dino Risi o L’audace colpo dei soliti ignoti (1960) di Nanni Loy, sono girati per grandissima parte in interni, negli studi. Solo poche riprese in esterno, con una breve trasferta della troupe a Milano. Una pratica in parte in uso anche oggi, ad esempio nella produzione dei Vanzina, in cui gli esterni vengono girati nei luoghi più noti e riconoscibili. Ma tornando alle cattedrali, vorrei richiamare un’immagine che a me è sempre sembrata molto cinematografica: quella, ne I promessi sposi, in cui Renzo, arrivando dalle parti di Monza, sale su una piccola altura e vede il Duomo.
Bisogna distinguere tra le due cose: l’identità della città e i luoghi identitari, che non è detto che siano coincidenti. L’identità di Milano per gli italiani è la modernità, di cui la città è icona, ossia il lavoro, i movimenti, i flussi, le luci, la fretta e la frenesia. I luoghi d’identità della città sono una cosa diversa; il cinema usa questi luoghi in modo molto marcato per offrire un’ambientazione allo spettatore.
Comparando il cinema alla lingua potremmo dire che ricorre a una sineddoche, la parte per il tutto.
Precisamente. Milano è il Duomo, è la Stazione Centrale, è la Galleria. C’è un film di Alberto Lattuada, Scuola elementare (1955), in cui i due protagonisti, romani, Billi e Riva, una coppia di comici allora famosi, passeggiano per la Galleria e Billi è frastornato dalle luci e dal movimento, ma si complimenta con l’altro per il. dinamismo che c’è intorno: “Complimenti, che Galleria!” esclama.. Riva accoglie i complimenti perché, in quanto milanese acquisito, la Galleria è qualcosa di suo.
Oltre a quelli già citati, ci sono altri luoghi: la Scala, ad esempio. Una scena bellissima di Cronaca di un amore (1950) di Michelangelo Antonioni è quella in cui Lucia Bosè si affretta ad entrare alla Scala; un’immagine che si può cogliere ancora oggi, perché come sappiamo chi arriva in ritardo resta fuori e si perde il primo atto. Lì Antonioni, che è regista raffinato, ferma quest’immagine e restituisce il senso di un rito tutto milanese. C’è un momento di coincidenza tra identità e luoghi identitari, ed è il boom economico. Nel film La notte (1961), sempre di Antonioni, i titoli di testa scorrono sulla facciata del grattacielo Pirelli (Gio Ponti, Antonio Fornaroli, Alberto Rosselli Pierluigi Nervi, 1956-60), con il sottofondo della musica jazz di un musicista milanese, Giorgio Gaslini. Lì si condensa l’identità non solo di Milano, ma di un’intera nazione nel momento del boom economico.
Lì il cinema fotografa sia un luogo che un tempo.
Sì. È di nuovo la lezione di Hitchcock: si parte da un luogo simbolo molto noto - e il Pirelli era stato appena completato, quindi era una novità assoluta - e si procede poi con la storia.
C’è un’interpretazione prevalente o ci sono diverse identità?
L’interpretazione è prevalente ed è quella già descritta: la città della modernità e del novecento che prende la sua forma. C’è però un film coevo che racconta Milano e restituisce la sua identità non tanto attraverso i luoghi identitari, quanto attraverso i personaggi e i loro comportamenti: Il posto (1961) di Ermanno Olmi, che racconta la condizione umana di un giovane al suo primo impiego. Un film perfetto. Olmi merita una digressione: ha girato tanto a Milano, e in generale è molto legato alla città, sia perché ha fondato una casa di produzione, la “Ventitre dicembre”, importante negli anni sessanta, sia perché ha lavorato a lungo con la Rai di Milano di corso Sempione.
Olmi è la nouvelle vague italiana. Lo stesso Olmi dedicherà a Milano un film documentario, Milano ‘83 (1983): sono passati più di venti anni dal Posto, si è esaurita la stagione del boom e delle grandi speranze degli anni settanta, così vivi anche se per certi versi tragici, e Milano risulta ora una città al nero. Fu un’opera molto criticata all’epoca, anche dall’amministrazione comunale, ma Olmi ci aveva visto giusto. Ricordo anche un film minore, Durante l’estate (1971), in cui c’è un disegnatore che ha il suo ufficio nella Torre Velasca oppure i Racconti di giovani amori (1967) in cui si mostra un capodanno nella nebbia e un ragazzino che va in una villa San Siro. Ecco, Olmi utilizza i luoghi ma ancor più le atmosfere di Milano. Anche nella sua autobiografia, Il ragazzo della Bovisa (1986), si coglie questa sua capacità di mantenere uno sguardo da fuori sulla città. Nonostante sia cresciuto e abbia vissuto a Milano, mantiene uno sguardo curioso e di aspettativa che si sorprende allo spettacolo della vita quotidiana urbana.
Questa considerazione mi fa venire in mente Walter Benjamin e la sua Infanzia berlinese, quando ragiona sulla distanza e sulle coincidenze tra il cittadino nativo e il cittadino forestiero. E di come a volte l’essere neofiti ci possa rivelare qualcosa dell’identità dei luoghi, inaccessibile nella quotidianità. Con riferimento a questo tema, penso a tre pellicole recenti, Happy Family di Gabriele Salvatores, Come l’ombra di Marina Spada” e Cosa voglio di più di Silvio Soldini, che ci restituiscono tre città assai diverse. Rispettivamente, direi insolitamente allegra e luminosa (borghese), una cupa e occulta (il proletariato invisibile dei migranti) e l’ultima metropolitana (operaia/piccolo borghese). E mi chiedo: i caratteri della città sono rimasti immutati nel passaggio del secolo o ci sono state modificazioni profonde che il cinema ancora non ci ha raccontato? Le pellicole girate a Milano negli ultimi anni propongono una lettura nitida dei cambiamenti o Milano è sempre la stessa?
C’è chi dice che Milano è sempre la stessa, io non lo credo. La città è molto cambiata negli ultimi venti anni, sia per la popolazione, perché il fenomeno migratorio ha riscritto la geografia di alcuni quartieri, sia perché sono cambiate le forme di aggregazione. Si pensi al rito dell’aperitivo – l’happy hour – un fenomeno ormai già quasi esaurito. Il cinema non ha raccontato questi cambiamenti, se non per piccolissimi tratti. Il film di Francesca Comencini, A casa nostra (2006), in parte ci prova. Lì la fotografia, livida e bellissima, di Luca Bigazzi ha un ruolo centrale. Bigazzi, milanese, ormai vive da molti anni nella capitale e in certo senso riesce ad attivare quello sguardo dall’esterno di cui si diceva prima. Nel film c’è una scena, ambientata in via Marina, dove si vede il distributore di benzina, (nel medesimo luogo in cui Foscolo incontra l’abate Parini ne I sepolcri), che è fotografata come un quadro di Hopper.
Vero. Ma lì, nel film della Comencini, Milano è solo durissima. Forzando la mano e spingendosi su un’ipotesi maliziosa, ti chiedo: non è che l’assenza di una nuova identità forte della città nel cinema risiede in un problema della città stessa, piuttosto che nelle difficoltà del mezzo? È vero, a Milano tendenzialmente si gira poco, rispetto ad altre città italiane e a Torino in particolare che con la sua Film Commission agevola e incoraggia le riprese, diversamente da quanto accade qui, dove sono più costose e complicate. Ma forse la stagione post-industriale e la declinazione di una nuova modernità non hanno ancora trovato i propri luoghi simbolici ed evocativi.
In Milano 55,1 - Cronaca di una settimana di passioni (2011), il documentario a cui ho collaborato insieme a molti altri per raccontare la campagna elettorale che ha portato alla sorprendete vittoria di Pisapia a sindaco di Milano, è ancora e di nuovo piazza del Duomo il luogo identitario per eccellenza, dove si ritrova la società, dove spontaneamente si radunano i cittadini per manifestare gioia ed entusiasmo. In altre parole i luoghi simbolici di una città non sono facilmente sostituibili.
Io credo che se oggi manca un’immagine forte della città è perché manca un investimento emotivo da parte dei milanesi stessi. Prevale il lamento, l’abbandono della città con il rito del week-end, la disaffezione. D’altro canto, però, è vero che tutte quelle manifestazioni in cui vengono aperti i palazzi e i monumenti solitamente inaccessibili (come nella settimana del FAI), o quelle diffuse nella città con il Fuori Salone, vedono una risposta massiccia dei cittadini e un riuso vitale: lì la città si accende, seppure solo per un giorno o per una settimana. Milano è ancora, pur sempre, la città di Stendhal: introversa e dove le cose belle sono nascoste. Queste iniziative rendono possibile un equilibrio che funziona. Penso a Lambrate durante il Salone del Mobile, dove si alternano atelier e gallerie di arte contemporanea in prossimità del vecchio borgo: lì è possibile visitare una mostra o un esposizione e dopo fermarsi a mangiare in una trattoria di quartiere.
In questo senso invece il bilancio della Triennale Bovisa, che partiva forse da un’analoga scommessa, è meno felice.
Sì, la Triennale Bovisa non funziona perché non c’è il dialogo con quello che le sta intorno.
In ogni caso, per quanto riguarda gli ultimi 10 anni, va detto che ci manca la distanza necessaria per cogliere alcuni aspetti. Venendo all’attualità è difficile storicizzare. Potremo valutare questa stagione più lucidamente tra qualche anno.
Ricorrendo di nuovo alla commedia, ci sono alcune cose di Aldo, Giovanni e Giacomo dove alcune trasformazioni recenti sono registrate con più chiarezza che altrove. In Chiedimi se sono felice (2000), ad esempio, si dà conto della trasformazione dei vecchi opifici in abitazioni; il loft in cui abita Aldo in via Mecenate racconta di una piccola rivoluzione nel modo di abitare, specie della cosiddetta creative class.
Aldo, Giovanni e Giacomo dovrebbero girare un film muto tutto dedicato a Milano. E al tram. Il tram è un altro elemento fortemente identitario. Solo a San Francisco si può vedere lo stesso anacronismo di un tram degli anni venti che attraversa la città.
Dove si concentra di norma il lavoro dei registi: quali sono i luoghi, quali le abitudini che il cinema ritrae e come cambiano dal dopoguerra ad oggi?
In larga parte abbiamo già risposto a questa domanda.
Si può aggiungere, però, che all’icona della modernità e del lavoro si accompagna quella della ricchezza. Il denaro e la società opulenta milanese rappresentano un filone nel cinema. In Io sono l’amore (2009) di Luca Guadagnino, Villa Necchi è di fatto il museo della borghesia milanese. Il regista ha storicizzato quella borghesia, una componente sociale che ha fatto grande la città, il cui miglior lascito è l’idea che la società cresce se si cresce tutti insieme. Nel film filtra un mood che ancora esiste.
Un altro film che fotografa bene una stagione milanese è La vita agra (1964) di Carlo Lizzani, tratto dal romanzo di Luciano Bianciardi. Rispetto al libro, il film non riesce a restituire il dinamismo sociale lì ben raccontato: un momento in cui tutto cambia con l’intellettuale di provincia che si inurba e finisce per lavorare nella pubblicità. Ma è interessante per la rappresentazione della Milano di Brera e di un certo mondo bohemienne, in seguito molto mitizzato. Il grattacielo simbolo, il “torracchione” da abbattere che nel libro è il Grattacielo Pirelli, in questo caso è la Torre Galfa (Melchiorre Bega, 1956-59). Un altro momento significativo del film è quando i protagonisti si trasferiscono in un “quartiere satellite”, che è a Pioltello, dove viene loro “spacchettata” e consegnata la casa secondo un rito di quegli anni. Ma ciò che si può dire de La vita agra è che racconta un periodo in cui era facile cogliere il presente, forse più di oggi. Lizzani gira diversi film a Milano, anche San Babila ore 20: un delitto inutile (1976) e Banditi a Milano (1968), un buon film di genere noir, di ispirazione americana, che mostra come la città sia già pienamente moderna dal punto di vista infrastrutturale: un paesaggio di svincoli e autostrade che solo cinque anni prima non avrebbe potuto utilizzare.
C’è poi un mediocre film del 1955 di Luigi Zampa, Ragazze d’oggi, il cui inizio è una carrellata sulla Darsena, con musica francesizzante di sottofondo. Milano come città popolare, con le lavandaie sui Navigli, e la città ancora incompiuta, come si vede quando le tre protagoniste salgono sulla Torre Breda (Luigi Mattioni, 1954) di piazza della Repubblica e la macchina fa una panoramica sull’intera città ancora piena dei buchi lasciati dalla guerra. L’urbanizzazione raggiunta si può constatare in un’altra Milano vista dall’alto in L’amica (1969) di Alberto Lattuada in cui un ragazzo, a dire il vero un po’ confuso, vorrebbe una città tutta di grattacieli.
C’è poi tutta la produzione del cinema minore della Scuola del Derby – i Pozzetto, gli Abatantuono – dove si mostra la città bohemienne dei Navigli, con il progressivo cambio di destinazione d’uso già dai primi anni ottanta, o la Brera non ancora gentrificata. In queste pellicole di genere si ha uno sguardo riflesso che restituisce la città come dato di fatto, senza interpretazione.
Quando invece il cinema autoriale gira a Milano, penso a registi come il già citato Antonioni, ma anche a Mario Monicelli in Romanzo popolare (1974) o a Luigi Comencini in Delitto d’amore (1974), sceglie quale città mostrare e sa come farlo.
Da questo punto di vista un film come Colpire al cuore (1983) di Gianni Amelio è esemplare: nell’ambientazione al quartiere Gratosoglio (Bbpr, 1963-71) lo sguardo del regista si posa sui vuoti della modernità. Una curiosità del film è che a interpretare il figlio di Trintignant è Fausto Rossi, il figlio cioè di uno dei progettisti delle case del Gratosoglio.
Ci sono anche altri registi meno eccelsi che, tra la fine degli anni settanta e i primi anni ottanta girano a Milano e ci mostrano aspetti interessanti della città, come Maurizio Nichetti che in Ratataplan (1979), con la gag del bicchiere d’acqua ordinato in un chiosco fasullo sul Monte Stella, ci offre un’immagine urbana non convenzionale, colorata e caotica.
Dunque bisogna distinguere tra lo sguardo d’autore e invece lo sguardo della macchina del cinema, che è uno sguardo complessivo e meno selettivo.
Le stagioni che ha vissuto la città si colgono attraverso il cinema? Ci sono film che riescono a raccontare la città e la sua epoca, lo zeitgeist? Con riferimento a due film coevi che hai citato - Colpire al cuore e Milano ‘83- si direbbe che con linguaggi e poetiche del tutto diverse la città rappresentata sia la stessa: una Milano triste, respingente.
Sì, è il periodo del riflusso, un passaggio di stagione. Dopo aver vissuto per strada negli anni settanta, si registra una sorta di ritiro, un ripiegamento. C’era stata nel 1980 a Torino la marcia dei 40.000. È l’esaurimento della stagione della politica, che allora non era solo impegno per cambiare la società, ma era anche la possibilità di “fare la rivoluzione”. Molti storici sostengono che il 68 è durato esattamente dieci anni, passando per il ‘77. I primi anni ottanta sono precisamente quel passaggio, alla fine di un periodo molto forte e connotato e prima di un’altra fase, quella della “Milano da bere”.
Per quanto si possa essere severi con quel periodo è di nuovo Milano ad essere un passo avanti, anche con la televisione commerciale che drena risorse e professionalità al cinema. Perciò chi aspirava a lavorare nel mondo degli audiovisivi non era più costretto a trasferirsi nella capitale, come invece è ben raccontato da Marco Weiss in Sinemà, memoir autobiografico di un giovane borghese milanese degli anni sessanta che si trasferisce a Roma con il sogno del cinema e collabora con Valerio Zurlini. Invece negli anni ottanta i giovani Silvio Soldini e Luca Bigazzi rimangono a Milano a fare il cinema. Ed è una novità.
Dunque esiste una specificità del cinema milanese, che lo rende diverso da quello romano o di altre parti d’Italia?
Direi di sì. È un cinema più sperimentale: il cinema d’animazione, il documentario, ad esempio, o comunque un cinema più leggero e meno di apparato, meno legato all’industria del cinema. Negli anni ottanta ci sono diverse esperienze esplorative: Filmmaker, ad esempio. Da lì sono venuti fuori Silvio Soldini, Paolo Rosa e Studio Azzurro, Giovanni Maderna, Alina Marazzi, Michelangelo Frammartino. Il cinema romano è meno sperimentale. In questo senso Salvatores non mi sembra rappresentativo del cinema milanese, proprio perché più di apparato, ora fa un cinema romano in salsa milanese.
Quali sono i legami tra cinema e architettura a Milano?
Ci sono una serie di registi - come Comencini, Lattuada, Monicelli – cresciuti negli anni trenta quando l’architettura era al centro degli interessi dei giovani intellettuali. Penso a un film come Mafioso (1962) di Lattuada dove c’è Alberto Sordi che interpreta un impiegato dell’Innocenti: nella prima parte c’è uno sguardo preciso sulla nuova architettura come vettore di modernità. Il senso dell’inquadratura di questi autori ha dei debiti verso l’architettura e il Movimento Moderno, così come il Movimento Moderno deve qualcosa al cinema.
Anche una figura come Aldo Buzzi, autore del Taccuino dell'aiuto-regista, rende evidente questo legame. Milano è un laboratorio della modernità tra le due guerre, non troviamo le stesse cose a Roma o a Torino. Una serie di intellettuali – Cesare Zavattini che viene da Parma, il napoletano Giuseppe Marotta, Leonardo Sinisgalli che viene dalla Lucania – arriva a Milano negli anni trenta e costruisce la società della comunicazione. Da qui nascono i media moderni.
Va ricordato che tutta la pubblicità viene fatta a Milano, tutti i Caroselli – dove si cimentano tanti bravi registi come il milanese Luciano Emmer – sono girati a Milano. Qui fa il suo esordio la società dei consumi e qui nasce nel 1957 il primo supermercato italiano, l’Esselunga, su modello di quelli americani. Carosello è interessante perché non è solo la vetrina di un prodotto, ma insegna agli Italiani cos’è il consumo.
L’altro aspetto è che noi a Milano non abbiamo avuto grandi attori. Le grandi maschere del cinema italiano - Sordi, Tognazzi, Manfredi, Mastroianni, Gassman - non sono milanesi. Il grande attore milanese è Dario Fo, che fa solo un film strambo come Lo svitato (1956) di Lizzani e, più ancora, Walter Chiari che è però un grande attore mancato.
Ma se bisogna scegliere un grande personaggio milanese al cinema di solito tocca al cremonese Tognazzi interpretarlo. Il cinema milanese non è cinema di attori, se non per quelli comici: tutta la scuola del Derby - Boldi, Teocoli, Pozzetto, Abatantuono a cui è da aggiungere Celentano - che, a partire dagli anni ottanta, farà molto cinema a Milano, ma lo sguardo sulla città non è autoriale, piuttosto lavora sui cliché.
Insegnando urbanistica, propongo sempre agli studenti di frequentare le espressioni dell’arte per interpretare i luoghi. Il cinema, in particolare, mi sembra possa mostrare qualcosa che nell’esperienza del quotidiano non si dà. Come si potrebbe descrivere quel “qualcosa”?
Il cinema è un momento di sintesi. Il paesaggio americano è il paesaggio del cinema americano. Il paesaggio nel cinema americano è qualcosa di grandioso e di epico. Si pensi a Furore (1940) di John Ford: un road movie di una suggestione incredibile. Applicando questo concetto alla città, il cinema è un momento di scelta, quindi tutto quello che è dentro l’inquadratura acquista in prima istanza un significato documentario. Questo vale anche per i film più sciatti, quando lo sguardo è quasi involontario come nel cinema di genere, ma nel momento in cui si posa il cavalletto e si sceglie un’inquadratura si opera una scelta.
Consiglio di rivedere Walter e i suoi cugini (1961), parodia girata dal mestierante Marino Girolami di Rocco e i suoi fratelli, con un grandioso Walter Chiari che interpreta cinque personaggi: è un film che comunque ci racconta una serie di cose su come era Milano nel 1961.
Diverso è il discorso del cinema d’autore: se rivediamo i film milanesi di Antonioni c’è sempre un secondo significato simbolico che è il risultato di una messa in scena alla quale, insieme al regista, collaborano lo scenografo, il costumista, il direttore della fotografia. L’esempio più chiaro è il cinema di Fellini che purtroppo non ha mai girato (o immaginato) Milano. Chissà cosa avrebbe scelto?
Se poi lo sguardo del regista viene da fuori, penso a Il tempo dei gitani (1989) di Emir Kusturica, coglie cose che è molto difficile vedere dall’interno, non solo per un regista milanese, ma italiano.
O come in Torna a settembre (1961) di Robert Mulligan, con Rock Hudson e Gina Lollobrigida, dove Milano, truccata da città della dolce vita, è tutta in ghingheri. Ognuno aggiunge qualcosa col suo sguardo. Abbiamo parlato prevalentemente di cinema italiano, ma i registi internazionali vedono altre cose. Noi milanesi cogliamo il dettaglio, ma raramente abbiamo uno sguardo rivelatore.
Trattando di scali ferroviari, una domanda sulla Stazione Centrale è ineludibile: come è utilizzata dal cinema?
Come questo edifico rappresenti l’altra grande cattedrale milanese si è già detto. Ma ci sono pellicole in cui il ruolo della Stazione è molto evocativo. In un altro grande film di cui non abbiamo ancora parlato, Rocco e i suoi fratelli (1960) di Luchino Visconti, l’arrivo in stazione è epico. La famiglia Parondi viene da un altro luogo, dalla Lucania, ma anche da un altro tempo storico. L’arrivo nella metropoli è l’impatto con questa fabbrica “liberty monumentale”, come la definisce Rossana Bossaglia. La stazione è perciò anche la porta, il luogo di accesso alla modernità. Tony Judt nel libro Lo chalet della memoria. Tessere di un novecento privato cita la Stazione Centrale e la paragona alle altre grandi stazioni del mondo, la Victoria Station di Londra o la Grand Central Station New York, altri luoghi molto cinematografici.
C’è un film di Giuseppe Bertolucci interamente girato nella Stazione Centrale, Oggetti smarriti (1980); ciò dimostra le moltissime possibilità narrative offerte dal luogo.
La Stazione Centrale può essere interpretata in diversi modi, ma il luogo condiziona la rappresentazione: uno spazio così gigantesco, assiro-babilonese, monumentale, per cui può andar bene sia che vi arrivino Toto e Peppino vestiti da cosacchi, sia che vi approdi la famiglia Parondi di Visconti.
Assistiamo poi a molte variazioni sul tema: Franco Piavoli gira un bellissimo documentario sui meridionali che arrivano in stazione negli anni sessanta. In quegli anni la stazione di Porta Nuova di Torino, poi ricostruita in Così ridevano (1998) di Gianni Amelio, e la Stazione Centrale sono le due grandi porte d’ingresso alla modernità.
Per certi versi, io penso che a tutt’oggi l’arrivo a Milano sia la Stazione Centrale. Se dovessi girare un film qui, partirei dalla Stazione e lo concluderei al Cimitero Monumentale. O viceversa: dipende dal film!
La ferrovia è un vettore di modernità. La Stazione, in questo senso, è un’icona della modernità. Il luogo prevale sullo sguardo e sull’interpretazione. È un edificio potente e di sintesi della civiltà borghese industriale che è il DNA della Milano in cui viviamo.

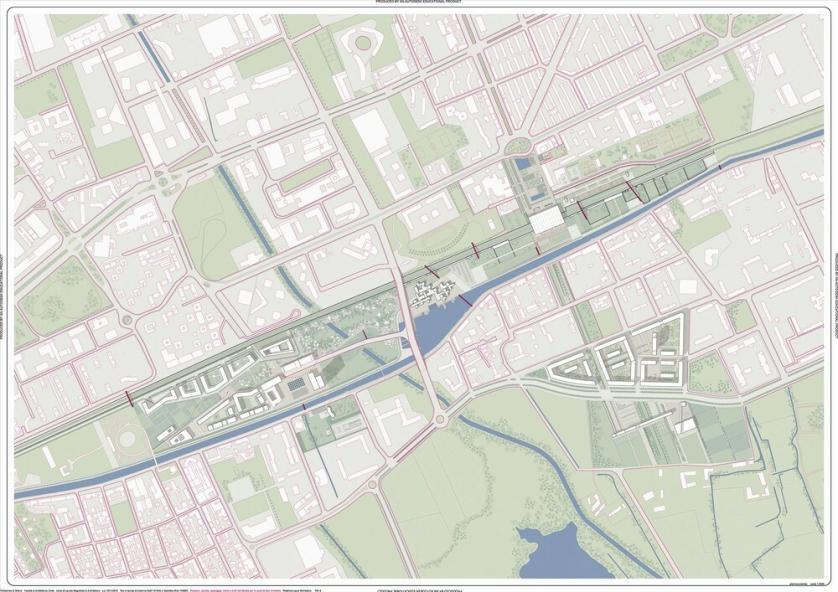




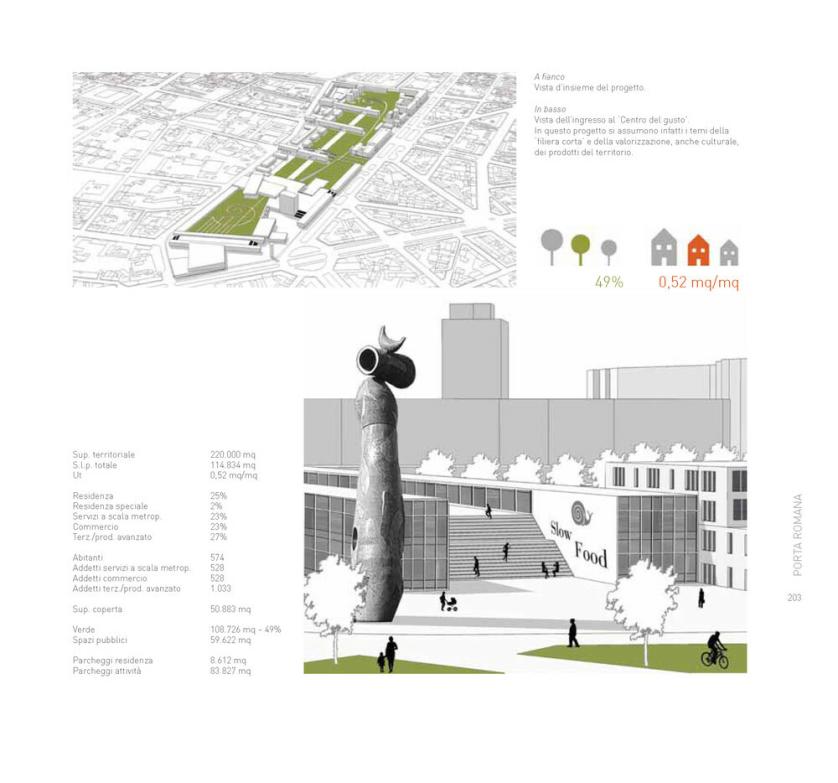

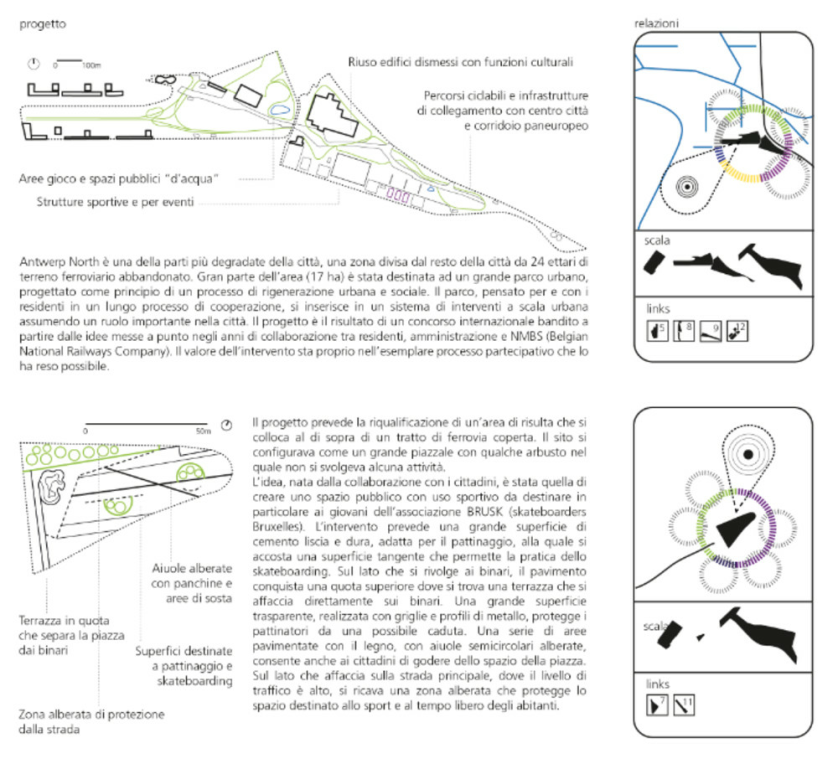
Nessun commento:
Posta un commento